IL CAMALEONTE
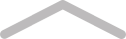
PRESENTAZIONE
“Il Camaleonte”Copyright © 2013 Matteo Menapace
Opera pubblicata e distribuita da: & MyBook un marchio di Caravaggio EditoreCasella postale 32566054 Vasto (CH)
Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento sono riservati. Nessuna parte di questo libro può essere usata, riprodotta o diffusa senza autorizzazione scritta da parte dell’autore o dell’editore.
Collana Editoriale Narrativa Prima Edizione Gennaio 2013
ISBN 978-88-6560-071-9
Foto di copertina: © Elisa Lazo de Valdez Progetto grafico: @LU_P_O
www.matteomenapace.it
A tutte le persone che sono in questo libro,
non sapendo di esserci
I. PROLOGO
1.
La luce filtrava dal finestrino come il flash di una fotografia, esplodendo nell’abitacolo con la forza di una bomba che squarcia il buio e acceca la notte. Rosso, verde, azzurro, giallo, viola sono i colori che attraversano bruscamente l’interno della vettura; si posano sui lineamenti del viso a formare una maschera che trasforma il volto, scivolano sulle spalle vestendo gli abiti di tessuti che non solo i loro, infine, cadono sulle mani dove una seconda pelle avvolge la prima come un camaleonte che copia il colore delle cose.
Al ritmo di un tamburo che batte incessantemente la sua melodia nel cielo, luce e buio si litigano il ruolo per condurre le danze in quella notte senza stelle. I colori irrompono nell’auto con la violenza di un fulmine poi il buio più nero attraversa ogni cosa inghiottendosi tutto.
È il ballo che anima una notte non uguale a tutte le altre.
Rosso. Boom! Lo scoppio in cielo di un fuoco pirotecnico rompe la densità della notte e il buio all’interno della macchina. Con il vigore di un breve istante, interrompe il silenzio solenne, ma per nulla imbarazzante, che nasce spontaneo in quelle quattro persone sedute nell’abitacolo nel sentirsi a contatto diretto con qualcosa d’inspiegabile che le terrorizza e le incuriosisce al tempo stesso. Il ritmo dei loro pensieri è la polifonia di mille voci che si sovrappongono, insistente nella testa come lo sono gli interrogativi cui non si riesce a trovare risposta. Lentamente l’impeto dello scoppio soffoca in un fruscio effervescente simile a quello prodotto da una bottiglia di acqua frizzante appena aperta, quando si accosta all’orecchio.
Poi di nuovo il silenzio, poi ancora il buio.
Verde. Un’altra stella si accese improvvisamente nel cielo portando con sé la scia di un boato sordo per poi svanire in una cascata di cenere e silenzio.
L‘ombra delle macchine che sfrecciano sulla strada uscì dalle tenebre che la imprigionavano e al chiarore della luce si distese e si allungò come un tappeto che si srotola sulla superficie liscia dell’asfalto.
Erano tre le macchine che s’inseguivano in fila ordinata, la prima e l’ultima erano le auto di scorta. Tutte e tre Mercedes‑Benz del 2002, carrozzeria blu scuro, vetri posteriori oscurati e cerchi in lega. Poco spazio separava le vetture. La velocità era sostenuta.
Anche questa volta la luce che abbagliava l’abitacolo si mescolò con i colori al suo interno: la pelle a contatto con la luce verde divenne smeraldo, i capelli si trasformarono in sottili filamenti d’erba e le ombre che contornavano il viso presero vita. Infine il buio che cancella ogni cosa, come un sipario che si abbassa sul mondo.
Azzurro. Sul sedile posteriore era seduto nel mezzo un uomo. Profondamente diverso dalle altre due persone sedute al suo fianco, diverso da quelle sedute davanti a lui, diverso da tutte le persone del mondo. In tutto nell’auto erano in cinque.
La luce che penetrava violentemente dai finestrini come un fiammifero acceso al buio scivolava sulla divisa da poliziotto dei due uomini seduti ai lati del sedile posteriore. Si posava prima sul cappello che la parte lucida della visiera rifletteva, scendendo sul colletto e sulla divisa scura. I bottoni e gli stemmi luccicanti si accendevano brillando come stelle sullo sfondo del tessuto in cui erano incastonati. Accarezzati da quella luce i due poliziotti sembravano manichini senza vita, immobili nel silenzio che avvolgeva ogni cosa. Il chiarore che rimbalzava nell’abitacolo era troppo flebile per riuscire a definire nettamente i lineamenti della persona seduta nel mezzo, quelli dei due poliziotti erano coperti dall’ombra che il cappello d’ordinanza gettava sui loro volti. La sua postura appariva rilassata. Era infossato nel sedile con la schiena mal poggiata allo schienale e la testa leggermente reclinata in avanti. In mezzo ai due poliziotti, immobili come statue di marmo, aveva la sensazione di poter percepire i loro pensieri come qualcosa di tangibile, come una corrente che attraversa l’aria e paralizza i loro corpi. Lui invece sembrava non pensare a nulla o comunque appariva molto tranquillo. Le braccia cadevano molli sulle ginocchia e un paio di manette luccicanti avvolgeva i polsi stanchi in due bracciali troppo scomodi da indossare.
Giallo. Nascosti dietro l’aspetto impassibile e composto dei due agenti sarebbe lecito aspettarsi chissà quali sofisticate riflessioni mentali o arrovellamenti psicologici, invece germogliavano nelle loro teste i pensieri più naturali che due persone, coinvolte in quella situazione senza sapere come, potessero avere. È strano il modo in cui le espressioni del corpo riescano a camuffare quelle del cuore senza tradire alcuna emozione, ma la curiosità per quella persona seduta così vicina a loro, trasudava dalla pelle e si spandeva come un profumo che satura l’aria della sua presenza.
Il poliziotto sulla destra stava pensando alla donna che più di tutte lo affascina e che riempie i suoi sogni nelle notti solitarie. Ogni qual volta la vedeva sullo schermo, un brivido di eccitazione gli percorreva la schiena e una sensazione perversa si faceva largo sotto i pantaloni troppo stretti. Infine lo attanagliava sempre la stessa tristezza che si prova di fronte a un desiderio irrealizzabile, a qualcosa d'irraggiungibile, quasi che l’insoddisfazione coincidesse con il desiderio stesso.
Darebbe ogni cosa per passare una notte con lei. È l’attrice italiana Monica Bellucci.
Se solo potessi assumere, anche per poche ore soltanto, le sembianze del marito Vincent Cassel... pensò dialogando con sé stesso.
Immaginò di trovarsi nel soggiorno di una villa lussuosa, mentre con passo sicuro si dirigeva verso la porta semichiusa di una stanza. All’interno intravedeva una donna distesa sul letto, avviluppata in un lenzuolo di seta chiaro che lasciava scoperta la superficie delle gambe e una parte del seno prosperoso. Era Monica. Il respiro si fece ansimante e la voglia era un fuoco che si accendeva lentamente. Il suo sguardo percorse minuziosamente ogni centimetro di pelle nuda che il chiarore della luna, filtrando dalla finestra, trasformava in marmo. Indugiò sulle pieghe sensuali della pianta del piede, arrampicandosi sulle caviglie sottili e infine percorrendo in lungo entrambe le gambe fino al bassoventre che la coperta lasciava intravedere leggermente. La voglia di leccare, baciare, fottere, divenne insostenibile. Il seno perfetto catturò i suoi occhi. La sua consistenza sembrava quella della felicità. Percorrerlo con i polpastrelli, racchiuderlo tra le mani, sarebbe stato come toccare la felicità. Il volto disteso sul cuscino era rilassato nel sonno.
S’immaginò la bocca di lei sul suo sesso, la lingua che si muove vorticosamente in un turbine di piacere. Non riuscì più a resistere e senza nemmeno accorgersene si ritrovò con la bocca sul suo piede. Il calore della saliva bruciava sulla pelle di quella donna bellissima. Senza svegliarsi lei si scostò leggermente, ma lui insisteva a percorrerla con la lingua, accecato da una voglia selvaggia finché con un sobbalzo Monica si svegliò, aprì gli occhi sorpresa, poi i lineamenti del suo viso tornarono a rilassarsi in un’espressione di tranquillità e stanchezza. Rivolgendosi a lui con voce calda disse
‑ Sei tu Vincent, mi sei mancato... ‑
Nella mente del secondo poliziotto un pensiero cominciò a prendere forma assorbendo completamente ogni contatto con la realtà circostante, ogni stimolo dall’esterno. Immerso in quel mondo di sua creazione, pensò al suo amico Ludovico.
La vita di Ludovico era la vita che avrebbe sempre desiderato vivere. Quante volte nel corso degli anni aveva sentito lo stesso ritornello ripetersi all’infinito nella sua testa: se solo fossi come lui... e quante volte l’invidia si era insinuata nel loro rapporto di amicizia come un ospite sgradito.
Ludovico era il tipo di uomo che riesce a far innamorare ogni donna di sé. Era sempre accompagnato da un’amante diversa e anche se sembrava impossibile, quella nuova era più bella e affascinante della precedente. L’intensità dei suoi occhi colore del mare gli conferivano un fascino irresistibile. Il suo sguardo aveva il potere d’incantare chi ci si specchiava dentro; era elegante di un’eleganza spontanea, brillante e spigliato con tutti. Aveva sempre la battuta pronta e in ogni momento ciò che diceva era la cosa giusta da dire. Sapeva come far ridere le donne e come farle arrossire con un complimento.
Ludovico non era uno da relazioni stabili, amava le donne con cui stava con una passione travolgente che si consuma lentamente giorno dopo giorno e poi svanisce senza rimpianti, come un fuoco che smette di ardere fino a spegnersi.
Al suo fianco mi sono sempre sentito un’ombra, in ogni luogo lui è il protagonista ed io una comparsa che nessuno riesce a vedere. Tutti i riflettori sono puntati su lui e gli occhi delle persone catalizzati sui suoi. Le donne non riescono a fare a meno di fissarlo e arrossiscono come bambine se il loro sguardo viene ricambiato. Io invece sono invisibile. Nessuno si accorge della mia esistenza. Gli occhi delle donne non indugiano mai su me, anzi sembra quasi che mi trapassino come se la consistenza del mio corpo fosse quella di un fantasma che nessuno riesce a vedere.
Anch’io voglio percorrere ogni sera il corpo di una donna diversa, baciare ogni volta labbra diverse, stringere tra le mani il seno di diverse donne e avere ogni sera un’amante nuova!
Una frase cominciò a rimbombargli nella testa sempre più freneticamente come un’ossessione cui non si vuole rinunciare. Scivolò nella gola scalciando per uscire, ma le parole s’incagliarono tra i denti stretti, come navi sugli scogli. Quello che seguì fu poco più di un sospiro: se fossi lui...
Viola. Seguendo il ritmo della macchina scorrere veloce lungo la strada, anche i pensieri dell’uomo ammanettato seduto nel mezzo, cominciarono a fluire, e come la superficie piatta di un mare calmo che s’increspa sempre più, il flusso delle sue riflessioni cominciarono a muoversi vorticosamente fino a diventare tempesta. Le sue labbra si aprirono restando semichiuse. Nel caos dei suoi pensieri trovò la forza di ordinare tra loro alcune parole in una frase che prese forma nel timbro monocorde di chi non ha mai provato cos’è la felicità
‑ Il mio io è come il nulla, sono tutti, ma non posso essere uno. Ho fatto quello che tutti, tutti i giorni vorrebbero fare: sono diventato qualcun altro ‑
Il silenzio solenne all’interno dell’auto fu interrotto da quelle parole con la stessa violenza con cui i fuochi pirotecnici rompevano la notte del cielo. Dal sedile passeggero anteriore si girò un uomo. Era uguale all’uomo con le manette ai polsi. Stessi lineamenti, stessi occhi, naso, bocca, capelli, stesso tutto. Era la sua copia. Poteva sembrare un suo gemello, ma quella copia era ancora più precisa, era identica in ogni più piccolo particolare. I due si fissavano negli occhi ed era come se si guardassero allo specchio.
‑ Qualunque cosa dirai potrà essere usata contro di te ‑
Disse l’uomo seduto davanti senza distogliere lo sguardo.
‑ Usatela pure ‑
II. BIANCA BOIS
2.
Mi chiamo Bianca Bòis. Ho molti ricordi dell’uomo che ho amato e non riesco a smettere di amare. Il suo volto, il suo sorriso sono diventati un’ossessione che rivedo in ogni persona che incontro. Ogni gesto, ogni parola, porta con sé il suo sapore, ogni oggetto che conosco si è trasformato nel ricordo di un momento trascorso insieme. Sono prigioniera della mia solitudine e come tale vorrei che i giorni corressero con la velocità dei mesi, degli anni, invece scorrono lenti come i secondi, inesorabili per chi ha perso ogni ragione per vivere. La mia sola compagnia è quella di un passato che non potrà mai più tornare e alle volte ho l’impressione di essermi io stessa trasformata in un ricordo di me, così lontana dalla vita reale, così distante dai momenti felici di un tempo, che l’unica cosa vera sembrano essere solo i ricordi. Ogni cosa è svuotata del suo senso, mi dedico alle piccole cose cui prima non davo importanza: riordinare la casa, rifare il letto la mattina, preparare dei dolci; con la lentezza di chi vuole vedere scorrere il giorno velocemente per non affogare troppo pesantemente nel dolore.
Sono morta dentro come lo sono le stelle che si spengono e muoiono nello spazio smettendo di brillare per sempre. Dalla Terra continuiamo a vederle come se ci fossero ancora, come se niente fosse successo, perché la luce che emanano impiega un lasso di tempo quasi infinito per percorrere la distanza che le separa dai nostri occhi. Vediamo la luce del passato nel presente e ci illudiamo che tutto sia esattamente come i nostri occhi lo vedono.
Dentro me c’è stata un’esplosione che mi ha uccisa. Sono morta, ma nessuno riesce a vederlo.
Quante volte capita di chiedersi: come sarebbe la vita se la persona che amiamo morisse all’improvviso? Che fine farebbero i sogni, i progetti, le speranze di una vita da trascorrere insieme? Che fine farebbe tutto quello che una persona ha costruito per il futuro? Al solo pensiero percepiamo una fitta allo stomaco e intuiamo per un istante il sapore aspro di un inferno che non vorremmo mai vivere, ma per quanto ci sforziamo di comprendere, non riusciremo mai a capire cosa si provi veramente. È come una persona che non ha mai visto il mare. Può immaginare il rumore delle onde, la spuma bianca che s’infrange sugli scogli e accarezza la banchisa, la morbidezza della sabbia sotto i piedi, ma non potrà mai sentire l’immensa emozione che si prova nel vedere quella distesa sconfinata d’acqua, fondersi all’orizzonte con il cielo.
Vivere le esperienze è il solo modo per capire.
Ricordo il nostro primo bacio. Non è stato sulle rive del mare, mentre una leggera brezza s’insinua tra i capelli fino a farli danzare nell’aria e il sole comincia a spegnersi nell’acqua tingendo il cielo dei colori dell’autunno, come si vede nei film; ma è stato ugualmente stupendo.
Lui si avvicinò piano chinando la testa verso il mio viso. Mi guardava intensamente, allora chiusi gli occhi e sentii la sua mano delicata sfiorarmi la guancia. Tremavo e avevo la stessa paura che si prova nel vedere realizzarsi i propri desideri. In un momento sentii le sue labbra calde sulle mie e la sua lingua scivolare nella mia bocca in una danza di piacere. Il profumo del suo sapore risvegliò in me una forza selvaggia che non sapevo di conoscere e una sensazione profonda accelerò il battito del mio cuore.
Quella sera avevamo appuntamento in un pub. Ricordo che a un certo momento lui si alzò e mi afferrò la mano dicendo solamente:
‑ Usciamo a prendere aria? ‑
Mi portò poco lontano di fronte alla vetrina di un negozio poco illuminato dalla luce dei lampioni e nascosto dal chiasso del locale, scortati entrambi dall’imbarazzo del silenzio. Poggiai la schiena al muro mentre con le mani cercavo a tastoni quella sicurezza che si prova nell’avere qualcosa a protezione delle spalle, però poco dopo mi sentii in trappola, senza via di fuga da quello sguardo che si specchiava nel mio.
Se adesso lo bacio non potrò mai più fare a meno di lui.
In quello stesso istante lui disse, nemmeno sapesse leggere il pensiero.
‑ Se adesso ti bacio, non ti lascerò più ‑
Fu di fronte a quella vetrina che l’espressione dei nostri sentimenti prese forma nel nostro primo bacio. Infine lo abbracciai stretto tra le braccia sussurrando al suo orecchio:
‑ Adesso non mi devi lasciare mai ‑
3.
Dalla finestra della mia stanza si riesce a scorgere un palazzo ergersi verso il cielo come un gigante che sovrasta ogni costruzione. È il condominio più alto della città. Nei miei ricordi di bambina qualsiasi distanza da un punto a un altro della città era misurata dalla dimensione con cui appariva ai nostri occhi; più diventava piccolo più mi stavo allontanando da casa. Il tetto è costituito da una grande pianura di cemento leggermente rialzata nel mezzo per permettere lo scolo dell’acqua piovana verso la grondaia. L’estate è utilizzato dagli abitanti del condominio che fissano dei lunghi fili da un capo all’altro dove stendere i panni bagnati ad asciugare al sole e come una sorta di spiaggia privata dove sistemare la sdraio per la tintarella. Piante di ogni genere, forma e colore sono sistemate a riempire ogni centimetro vuoto di quello spiano al punto da trasformarlo in una vera e propria foresta, ideale per i giochi dei bambini. Un parapetto in cemento separa quell’isola felice dal vuoto che la circonda.
Ora mi trovo seduta sul parapetto di quel tetto, con le gambe ciondolanti nel vuoto e lo sguardo perso nell’infinito della città che si staglia di sotto. Il freddo ha costretto i condòmini a traslocare nelle proprie abitazioni le piante, che altrimenti non sarebbero sopravvissute al freddo, lasciando deserto e triste quel luogo, mentre i fili del bucato abbandonati alla loro inutilità sembrano le corde rotte di una chitarra vecchia che da qualche tempo ha smesso di suonare. In questa notte senza stelle tutto di quel tetto è freddo cemento senza vita.
Io e Mari abbiamo trascorso gli anni dell’infanzia e quelli dell’adolescenza giocando in quel luogo. Eravamo grandi amiche della figlia del portiere, una persona buona e generosa che ci aveva regalato una copia delle chiavi: una per la porta principale e l’altra per la porta d’accesso al tetto. Nel corso degli anni le ho conservate con cura e ogni volta che mi sentivo triste mi rifugiavo sopra quel tetto, sperando che i ricordi felici del passato dissolvessero ogni mia preoccupazione. Lo stesso motivo per cui mi trovo ora.
Respiravo un’aria familiare come se i momenti trascorsi in quel luogo avessero lasciato un’impronta nell’aria. Sentivo quell’atmosfera immutata negli anni attraversarmi fino a riempire ogni mio senso, accendendo nella mia mente le sensazioni del passato con la stessa leggerezza di un tempo. Ho sempre pensato che alcuni luoghi avessero un’anima capace di conservare intatte le emozioni vissute intensamente per poi rievocarle in noi sotto forma di sensazioni; come il profumo di una rosa che risveglia nella mente di chi la odora la sua immagine, allo stesso modo il profumo che si muoveva nell’aria mi faceva riscoprire i momenti di un passato lontano. I ricordi cominciarono ad affollare la mia testa, intrecciandosi tra loro, fondendosi, scalciando per uscire. Gli ingranaggi dei miei pensieri, a contatto con quell’atmosfera rassicurante, iniziarono a muoversi, liberi dalla sofferenza e dal dolore che solo quel luogo riusciva, almeno per un attimo, ad alleviare.
È il mio posto segreto. Qui mi sento libera.
Osservo la città dall’alto animarsi al chiarore della luna: le luci che si accendono una dopo l’altra galleggiando nel buio come tante lucciole immobili, i colori bizzarri delle insegne dei locali, le persone che la distanza trasforma in formiche, il suono delle macchine sull’asfalto trasportato dal vento. Mi sento uno spettatore che assiste allo spettacolo della notte che prende vita.
Osservando il mondo da questo nuovo punto di vista sono folgorata dalla sensazione di come tutto in realtà sia così profondamente inutile. Le persone somigliano a piccoli animali indaffarati a calpestarsi i piedi a vicenda, a trarre profitto dalle sfortune altrui e che, nonostante vivano in gruppo, pensano solo alla propria sopravvivenza. Riesco a vedere le cose con oggettività, con il distacco di chi non si trova nella mischia e la conclusione che traggo è che in fondo siamo tutti così insignificanti: un puntino sulla faccia della terra, un piccolo puntino nero nell’immensità dell’universo. Tutti in cerca di una soluzione alla solitudine.
Ho l’impressione che se un dio esistesse, guarderebbe verso noi con lo stesso occhio egoista, fregandosene di tutto tranne che di sé stesso.
Ogni essere vivente su questa terra è solo e di solitudine è fatta la sua vita. Le piante, le bestie, di nient’altro hanno bisogno che di loro stessi. Alcuni animali vivono in branco, gli uccelli in stormi, i pesci in banchi, però solamente per una meccanica legata alla sopravvivenza individuale, che comprende i metodi di attacco per catturare la preda e modi per non diventare loro stessi la preda. Perchè l’uomo non accetta la propria natura, il proprio essere un individuo unico e perciò solo? Lontana dall’uomo è l’idea che l’amore sia un’esperienza da vivere nel segmento di viaggio fatto insieme e non una cura miracolosa alla parola solitudine.
Scesi dal parapetto con un balzo senza riuscire a trovare risposta all’interrogativo che mi avrebbe accompagnato lungo la strada di casa.
Perchè se la natura dell’uomo è di essere solo, soffro tanto?
4.
Andai in cucina a controllare se la torta di mele che stavo preparando fosse pronta. Ancora qualche minuto. Richiusi lo sportello del forno e sistemai in fila ordinata i dolci che avevo preparato sul tavolo, uno fianco all’altro finché non fui soddisfatta della loro disposizione. Mi resi conto in quel momento che la mia propensione all’ordine aveva qualcosa di morboso e mi tornarono alla mente le parole di un libro che non ricordo di aver letto; dicevano che l’ossessione all’ordine nasce dal bisogno di avere ogni cosa sotto controllo, si sviluppa nelle persone che hanno paura di cambiare il proprio modo di vivere e per questo non riescono a staccarsi dalle abitudini. In quell’istante mi accorsi quanto ero cambiata. Quando ero ragazza fantasticavo sul mio futuro: immaginavo una vita talmente piena di emozioni, avventure, colpi di scena, che qualche bravo romanziere ci avrebbe di sicuro scritto un libro di successo. Invece mi guardo adesso e sono tutto ciò che non volevo diventare.
Ero stanca. Mi sdraiai di traverso sul letto della mia camera con un sospiro di sollievo. La luce entrava dalla finestra aperta, insieme a una leggera brezza che muoveva le tende conferendogli un soffio di vita. Era una giornata bellissima. Dalla visuale in cui mi trovavo riuscivo a intravedere una porzione di cielo attraverso la finestra. Rimasi a fissarlo con la mente sgombra, incantata dal senso di serenità che quel triangolo azzurro riusciva a trasmettermi. Lentamente cominciai a sentire il peso del suo corpo sul letto sprofondare tra le coperte e il calore della sua pelle a contatto con la mia, mentre la sua voce rassicurante mi avvolgeva come un eco intrappolato tra le pareti.
Un altro flashback, un altro ricordo di un passato che non potrà mai più tornare.
‑ Hai mai pensato come sarà il nostro matrimonio Bianca? Io ho già deciso in ogni più piccolo particolare come dovrà essere quel giorno ‑
‑ Ah davvero... tu hai già deciso? Va bene, allora sentiamo: Come sarà il nostro matrimonio? ‑
Eravamo entrambi sdraiati sullo stesso letto su cui mi trovo ora, pancia all’aria, con lo sguardo fisso al soffitto. Era mattina. Anche quel giorno il sole splendeva alto nel cielo e nella mia stanza.
‑ Prova a immaginare una spiaggia bianca, fatta di una sabbia talmente fina che camminarci sopra sarebbe come camminare sulle nuvole; in una terra vergine dell‘America Latina. Il mare color smeraldo che si stende come un velo fino all’orizzonte, trasparente al punto da poter vedere i pesci nuotare liberi sul fondale. Prova a immaginare il rumore dei gabbiani che si mescola con quello costante delle onde che si appiccicano sulla spiaggia ‑ Mi girai sulla pancia reggendomi la testa tra le mani, attenta a vedere le parole che uscivano come immagini dalla sua bocca e il luccichio dei suoi occhi traboccanti di sogni.
‑ A metà spiaggia è sistemato un altare incorniciato da così tanti fiori da far invidia ai colori della barriera corallina. Ci saranno tutte le persone a noi care. Infine, sistemata a lato dell’altare, ci sarà una piccola orchestra che suonerà... ‑
‑ Suonerà “All you need is love” ‑
Dissi interrompendo di colpo la sua descrizione
‑ Come “All you need is love”? ‑
Rispose con un sorriso che andava disegnandosi sulle labbra.
‑ Ma si dai! La canzone dei Beatles. Dovrà suonare alla marcia nuziale, solo quella canzone ‑
‑ E come mai Bianca? ‑
Chiese assecondando la sua curiosità.
‑ È ovvio! Perchè tutto ciò di cui ho bisogno sei tu ‑ Scoppiammo entrambi in una fragorosa risata che arrivò spontanea e non riuscimmo a trattenere. Cambiai nuovamente posizione e andai cavalcioni sopra lui, gli presi i polsi con le mani tenendoli stretti contro il materasso e dimenandomi cominciai a cantare:
‑ All you need is love...ta tata tara... all you need is love... ta tata tara... love, love... ‑
Non smetteva più di ridere. Le sue mani cominciarono a danzare nell’aria trasportate dalle mie, seguendo il movimento del mio corpo che ondeggiava sopra lui.
Il suo viso si rilassò in un sorriso appena accennato, anche i suoi occhi sembravano sorridere mentre fissavano i miei. Con la sincerità di un bambino, senza vergogna disse:
‑ Ti amo ‑
Suonò il citofono. Sapevo che era Mari, ma risposi ugualmente.
‑ Chi è? ‑
‑ Sono Mari ‑
Varcò la soglia dell’appartamento e mi salutò con un abbraccio e due baci affettuosi sulle guance.
‑ Diventi sempre più bella. Sembra che tu ringiovanisca ogni giorno che passa ‑
Mentre pronunciava queste parole, si tolse sciarpa e cappotto, lanciandoli senza cura sullo schienale di una poltrona. Mi girai in direzione dello specchio fissato sulla parete opposta del soggiorno, per cercare conferma alle sue parole, ma l’immagine che vidi riflessa arrivò come una decisa smentita.
Sono mesi che il mio viso non vede un po’ di cipria, un tocco di rimmel o una passata di rossetto. Ho rinchiuso i miei oggetti di bellezza, così indispensabili per ogni donna, in un cassetto del bagno talmente nascosto nelle profondità della mia memoria che mi sono perfino scordata della sua esistenza.
Quel pensiero mi fece sorridere. È strano come le cose, una volta importanti, possano diventare con il tempo assolutamente superflue.
Sedemmo in soggiorno come eravamo solite fare.
‑ Come stai Bianca? ‑
‑ Bene ‑
Risposi.
A Mari interessava veramente sapere come mi sentivo, si sforzava di comprendermi, ma non avrebbe mai potuto capire, quindi mi limitavo a rispondere: bene. Entrambe sapevamo che mentivo.
Mari cominciò a parlare. Cercò di consolarmi, di consigliarmi; mi propose di prendere in considerazione l’idea di rivolgermi a uno psicologo, poi s’improvvisò lei stessa psicologa dicendo che per superare le situazioni difficili bisogna sempre cominciare dalle piccole cose come per esempio ricominciare a curare il proprio aspetto esteriore per aumentare l’autostima in sé stessi. Insomma parlò a lungo mentre la fissavo intensamente negli occhi. Non erano però le sue parole che m’interessavano, ero invece incuriosita da tutti quei segni che accompagnano l’atto linguistico, come le espressioni del viso e quelle del corpo. Vedevo le sue labbra muoversi, ma il suono delle parole arrivava come un brusio di sottofondo alle mie orecchie. Fui sorpresa nell’accorgermi con quanta regolarità le sue frasi s’interrompevano per permetterle di riprendere fiato. Impercettibilmente inarcava il sopracciglio destro quando il tono della sua voce aumentava e le sue mani sembravano quelle di un direttore d’orchestra mentre seguivano il flusso del discorso in modo da rafforzarne il senso.
‑ ...cerca di uscire da questa casa fatta di ricordi, il modo migliore per dimenticare è disfarsi del passato e stando chiusa qui certo non ci riuscirai. Vedrai che il tempo farà la sua parte però tu dovrai dargli una mano ‑
‑ Forse hai ragione Mari, spero che questo tempo passi veloce. Tu mi vuoi molto bene ‑
‑ Come due sorelle ‑
Rispondeva sempre a quel modo e mi piaceva sentire quella risposta, mi faceva sentire meno sola.
Mari è mia sorella minore. Quando ha tempo viene sempre a trovarmi pensando che la sua presenza possa in qualche modo riuscire a farmi sentire meglio e in effetti, è proprio così. Lavora la sera come cameriera in un ristorante della città per pagarsi gli studi all’università. È una persona vivace, piena d’iniziativa, che si butta nella vita come ci si butta da una scogliera: con tanto coraggio e gli occhi chiusi. Almeno è questo che ho sempre pensato di lei. Una volta anch’io ero così, ma adesso è tutta un’altra storia.
Sono contenta che sia passata a trovarmi.
Suonò il timer del forno, la torta di mele era pronta. Andai in cucina e la sistemai in ordine con le altre sul tavolo.
‑ Vuoi un pezzo di torta Mari? È appena sfornata ‑
Dissi a voce alta per farmi sentire nel soggiorno.
‑ No grazie ‑
Rimasi per un istante ipnotizzata a fissare i dolci disposti in ordine sul tavolo.
È sorprendente come il nostro organismo reagisca agli avvenimenti dolorosi della vita in modo da attenuare la sofferenza. L’istinto alla sopravvivenza si attiva a creare delle difese che ci proteggono dal dolore, così come succede per il corpo anche nella psiche umana vengono erette delle barriere protettive, che non sono una medicina che ci aiuta a guarire, ma un modo per sopportare meglio. Alcune persone trovano nello scrivere una forma di evasione, altre si dedicano alle pulizie di casa, altre ancora collezionano oggetti rari. Io invece preparo dolci. Non amo i dolci, non mi sono mai piaciuti nemmeno da bambina, ed è buffo come la natura del nostro intelletto qualche volta si prenda gioco di noi, facendoci sentire gratificati nel fare cose che non ci piacciono.
Non so dire quando questa abitudine sia cominciata, ma in qualche modo mi fa sentire meglio. Ogni giorno preparo un dolce diverso che dispongo in file ordinate sui ripiani della cucina come fossero tanti oggetti preziosi da mettere in mostra. Mi fermo a guardarli e mi domando se siano veramente buoni, se davvero il loro aspetto così invitante non nasconda un sapore sgradevole. Come faccio a sapere che non siano marciti all’interno? In fondo anche il mio aspetto nasconde qualcosa di marcio: la mia anima morente che avvizzisce come un fiore senz’acqua.
‑ Bianca, ti ricordi di Paula? La mia amica d’infanzia che ora lavora come giornalista ‑
‑ Si certo mi ricordo di lei ‑
‑ Oggi l’ho incontrata per caso e mi ha raccontato una cosa veramente strana. Era visibilmente agitata e continuava a guardarsi intorno come fosse inseguita da qualcosa o qualcuno. Il lunedì della settimana scorsa suo marito è rientrato il pomeriggio, orario insolito perchè il suo lavoro lo trattiene sempre fino a sera e alle volte anche oltre, giustificandosi con lei dicendo che aveva preso alcune ore libere per trascorrere del tempo insieme. Mi confidò che si era accorta subito che c’era qualcosa di strano in lui, lo trovava diverso dal solito. Quel pomeriggio avevano fatto l’amore in un modo così passionale e tenero al tempo stesso che le ricordava il primo periodo dell’innamoramento. Poi lui era uscito di casa per recarsi nuovamente al lavoro. Era rientrato la sera, ma con grande stupore di lei, non si ricordava assolutamente di quel pomeriggio di passione, sosteneva invece che di non essersi mosso durante tutto il giorno dal suo ufficio tranne che per recarsi al ristorante dove era solito passare la pausa pranzo ‑
‑ Probabilmente se n’era dimenticato, sai come sono a volte gli uomini, oppure fingeva di non ricordarsi per prendersi gioco di lei ‑
Dissi sedendomi sulla poltrona del soggiorno di fronte a Mari.
‑ In realtà anche Paula all’inizio aveva pensato così. Aveva ipotizzato perfino che si fosse trattato di un sogno. Però quel sogno era così realistico... mi disse. Fatto sta che non diede molta importanza alla cosa, però il giovedì della stessa settimana capitò un’altra volta. Fece l’amore con il marito il pomeriggio e quando lui tornò la sera non si ricordava di nulla. Molto strano vero? ‑
‑ Potrebbe aver avuto delle allucinazioni. Succede quando le capacità d’inibizione del subconscio non funzionano come dovrebbero. Accade praticamente quello che succede alle persone quando sognano di notte e si ha l’impressione che le immagini prodotte dalla nostra mente siano reali ‑
‑ Non è così perchè Paula, preoccupata dalla situazione, si è fatta visitare da diversi specialisti nel campo della psicologia, i quali dopo qualche seduta, hanno dichiarato l’inesistenza di alcuna patologia del genere. Inoltre alcuni colleghi del marito hanno confermato il fatto che non si fosse mai allontanato dal luogo di lavoro prima di sera ‑
Rimasi con lo sguardo fisso nel vuoto cercando di trovare una soluzione possibile a quello strano caso.
‑ Poi è successo nuovamente? ‑
‑ Per ora no, però Paula adesso è terrorizzata. Mi ha confidato che quando il marito torna a casa lei gli pone un quesito cui solo loro due conoscono la risposta e così si sente più tranquilla ‑
Si alzò.
‑ Adesso devo andare Bianca. Torno a trovarti presto e la prossima volta assaggerò uno dei tuoi dolci. Promesso ‑ Continuavo a riflettere su quella strana storia, mi sentivo un’investigatrice in mezzo ad un mistero, ma troppi erano i punti interrogativi e i miei pensieri giravano in tondo come un cane che si morde la coda. La accompagnai alla porta.
‑ Ciao Bianca ‑
Disse con un bacio sulla guancia. Non riuscii a confessarle quanto mi faceva piacere che fosse passata a trovarmi, forse per un sentimento di stupido orgoglio, ma ero sicura che lo avesse capito anche senza bisogno di parole quanto fosse importante per me.‑ Ciao Mari, grazie ‑
5.
‑ Signori e signore la festa è già cominciata! Musica, danze e stelle colorate! Quest’anno i carri più belli del mondo sfileranno per le strade fino a sera! Quindi venite, fatevi avanti, l’allegria è il vero protagonista! Niente facce tristi, solo sorrisi e scherzi! La gara dei carri è iniziata, decidete voi qual è il più bello e ricordate: a carnevale ogni scherzo vale! ‑
Gli altoparlanti diffondevano la voce del presentatore dal palco in ogni punto della città. I giochi dei bambini, le urla dei grandi, le risate, facevano coro a quelle parole mentre la musica si spandeva nell’aria densa di rumori.
Camminavo in mezzo a una giungla di colori, ostacolata dalle maschere bizzarre che mi si paravano davanti togliendomi la strada. I miei occhi erano pieni di quel fiume di persone dai visi sorridenti che dimenticavano per un giorno i problemi della vita e si lasciavano trasportare dall’elettrica follia che attraversa ogni cosa. Un’orgia di persone accalcate le une sulle altre, che urlavano, ridevano, soffiano a pieni polmoni attraverso fischietti colorati che si srotolavano come la lingua di un serpente. In quella calca umana ognuno dava libero sfogo a sé stesso, senza limiti di vergogna o pudore perchè protetti dall’anonimato delle proprie maschere.
Dall’alto cadeva una pioggia fatta di coriandoli e strisce di carta, che ricoprivano le strade e la folla sottostante dei loro colori, mente le stelle filanti volavano come i fili di una matassa lanciata verso il cielo. L’odore pungente dei corpi ammassati tra loro si mescolava nell’aria a quello chimico dello zucchero filato in una fragranza che mi dava le vertigini.
In testa al corteo dei carri che sfilavano senza sosta tra le arterie della città, un gruppo di ballerine dai corpi perfetti, vestite di sole paiette colorate, aprivano la strada muovendo ogni muscolo freneticamente al ritmo della musica che incalzava sempre più prepotentemente.
Ero uscita in strada nella speranza che il clima di festa riuscisse in qualche modo a contagiarmi, facendomi dimenticare per un istante ogni cosa, invece percepivo il disagio di trovarmi in mezzo a così tante persone sorridenti e la vergogna di essere l’unica a non sorridere.
Sono sola di fronte a un esercito dalle divise arcobaleno, che imbracciano le loro bacchette scintillanti come fossero fucili pronti al fuoco da puntarmi addosso. Sono colpevole della mia inadeguatezza, colpevole di sguazzare in quel mare come un pesce fuor d’acqua. Vedo le loro mani immergersi in grandi sacchetti di plastica e a pugni chiusi lanciare in cielo le bombe colorate che precipitano al suolo e mi colpiscono con la forza dei loro sguardi accusatori. Sento il peso di quei sorriso stampati a 36 denti, prendersi gioco del mio dolore e condannarmi a un verdetto di colpevolezza per non aver preso parte al loro banchetto di follia.
Nascosto sotto la veste di cartapesta dei carri batte un cuore metallico di macchinari da guerra pronti a puntare dito e grilletto contro me. Il rumore dei cingoli che avanzano sull’asfalto è assordante. La musica si trasforma nel boato di una mitraglia che spara colpi a raffica. Vedo il sangue schizzare nell’aria in filamenti di stelle colorate che imbrattano ogni cosa. Non un viso amico, solo maschere grottesche scorrono dentro i miei occhi. L’angoscia che cresce è come una paralisi. L’odore della battaglia si diffonde nei miei polmoni come una pestilenza che sancisce la mia presenza a quella festa con una sconfitta. Cerco di defilarmi, di nascondermi, ma sono nel mezzo; allora attendo la voce del presentatore annunciare la fine della guerra e il mio esilio.
‑ Signori e signore! È venuto a trovarci un amico, un grande artista... ‑
La musica si abbassò restando in sottofondo.
‑ Una star internazionale, che ha accolto il nostro invito e oggi è qui con noi in questo giorno di festa accompagnato dalla moglie Natalie! Il suo ultimo brano ha scalato le vette di tutte le classifiche. Sono sicuro che avete già capito di chi sto parlando... ‑
Intanto gli addetti ai lavori erano impegnati ad allestire il palco per lo spettacolo portando in scena gli strumenti musicali necessari all’esibizione.
‑ Ho l’onore di presentarvi... ‑
Silenzio d’attesa.
‑ Nick Cove!! ‑
Esplose un boato di acclamazione tra la gente, sovrastato dalle urla di alcune ragazzine che avevano raggiunto la prossimità del palco e si agitavano saltellando come in preda ad una crisi epilettica. Nick salì sul palco tenendo per mano la moglie Natalie, la quale si defilò subito in disparte sul fondo del palcoscenico mentre il marito raggiungeva il presentatore che gli tendeva il microfono.
‑ Allora gente, siete pronti!? Diamo una botta di vita a questa festa del cazzo! ‑
In quell’istante si guadagnò tutta la mia antipatia, dopo poco attaccò la canzone.
Natalie era con le spalle poggiata alla ringhiera del palco, circondata da due enormi guardie del corpo in giacca e cravatta scura, occhiali da sole sul viso e auricolare all’orecchio per restare sempre in contatto tra loro. Si accese una sigaretta. Il suo sguardo basso fissava il vuoto, ma non sembrava per nulla intimidita nel trovarsi sul palco circondata da tutta quella gente ubriaca di allegria, anzi sembrava del tutto indifferente alla situazione. Osservava, alzando di tanto in tanto gli occhi dal vuoto che l’assorbiva, il marito agitarsi sul palco con quell’aria di superiorità mista a compassione con cui una madre osserva l’eccessivo esibizionismo del figlio. Riconoscevo nel suo sguardo la stessa sensazione di smarrimento che provavo io nel trovarmi dove non avrei voluto essere. Forse io e lei eravamo le uniche persone presenti a quella festa che non volevano partecipare. Abbassò lo sguardo e prese una boccata di sigaretta.
Ho un sesto senso nel riconoscere al volo com’è fatta una persona, ma nei suoi occhi brillava una luce particolare che non riuscivo a decifrare. Ripensai all’espressione del suo viso da quando l’avevo vista salire sul palco a quel momento. C’era una cosa: non l’avevo vista sorridere. Improvvisamente una mano aggrappata al mio vestito mi trascinò fuori dai miei pensieri. Mi voltai e vidi una bambina vestita da fata turchina, abito celeste e cappello a punta dal quale usciva una criniera di strisce argentate, che mi fissava dal basso verso l’alto con i suoi grandi occhi azzurri. Reggeva in mano una bacchetta che finiva all’estremità in una stella anch’essa argentata. Spalancò la bocca incrostata di zucchero filato appiccicoso mettendo in mostra i suoi piccoli denti distanziati uno dall’altro. Avvicinò la punta della sua bacchetta magica e mi colpì leggermente su una gamba, poi disse con voce soddisfatta:
‑ Adesso sei morta ‑
6.
Riconosco il mio volto stanco prendere forma nel finestrino insieme ai sedili di plastica e al pavimento grigio dell’autobus. Guardo fuori cercando d’intravedere il mondo esterno scorrere veloce sotto i miei occhi, ma ciò che vedo è l’immagine riflessa di uno specchio che riempie la mia visuale di cose già viste, impedendomi di scorgere la vita che si muove dall’altra parte del finestrino. Finché un lampione non illumina di tanto in tanto la strada, spalancando ai miei occhi le stelle del cielo e le luci della città fondersi nel buio di quel grande universo che è la notte, brillando all’unisono come tante fiaccole accese.
La mia testa a contatto con quel freddo vetro è attraversata dalle vibrazioni del motore che penetrano il mio cervello con la violenza di una scossa elettrica. Sento le irregolarità dell’asfalto a contatto con i pneumatici risalire lungo le gambe fino a farmi sobbalzare, allora premo con maggior forza la nuca contro il finestrino al punto da sentire le scosse riempirmi le orecchie fino a traboccare.
La mia pelle colpita dalla luce intensa all’interno dell’autobus assumeva il colorito pallido di un cadavere e le pupille si restringevano fino a diventare due piccoli néi nell’iride.
Questa sera ho capito cos’è una stella e perchè su di essa non vi è amore: perchè è sola in mezzo ad altri miliardi di stelle. È stupido da parte sua seguire un’orbita sempre uguale, nel corso di anni luce, sovrastata da una forza più grande, non si ribella.
E come una stella mi dirigo in un’orbita sempre più serrata e ad ogni tentativo di ricercare la libertà, mi confino sempre più ai bordi dell’universo. È per questo che alle volte le stelle cadono, perchè sono invidiose dell’amore tra le persone, di quell’amore che ci fa sentire vivi.
Mancavano cinque fermate alla mia e tutto quello che riuscivo a pensare era: Che torta preparerò domani?
Prima fermata. Si alzò una signora reggendo nelle mani due grandi borse del supermercato colme di chissà quali oggetti. Era avvolta in un impermeabile lucido colore rosso e un cappello di lana verde le copriva il capo nascondendo il viso. Dal modo di camminare intuii che si trattava di una persona piuttosto anziana, il passo era lento e l’andatura sbilanciata dal peso delle borse che si portava appresso. Scese i gradini dell’autobus uno da uno, un piede alla volta, finché non fu in strada.
Quando si invecchia la percezione che si ha del tempo si trasforma, non si ha più la fretta di fare le cose perchè non si ha più nulla da fare, veramente. I giorni cominciano a scorrere lentamente, i minuti diventano ore e i mesi anni, la frenesia della giovinezza, dei giochi, del lavoro, rallenta il passo sostituita dalle abitudini e dalla routine sempre identica di ogni giorno. Il mare burrascoso dell’iniziativa e dell’intraprendenza diventa la superficie piatta e pigra dell’attesa. Anch’io percepivo il tempo a quel modo, avevo imparato presto cosa significa guardare al futuro e non vedere niente. Ero invecchiata di colpo e mi trascinavo dietro la sofferenza come due borsoni troppo pesanti da trasportare.
L’autobus ripartì e con esso i miei pensieri alimentati dal combustibile del mio male. Pensai al suicidio. Molte volte avevo immaginato di togliermi la vita, un pensiero che ha attraversato ogni persona nei momenti difficili, più o meno fortemente. Non ho paura del dolore, sono convinta che ciò che si provi nella morte sia un dolore senza cicatrici, un dolore senza memoria, come una sofferenza che non ha conseguenze se non quella di sfociare nel nulla. Per questo non mi interrogavo mai su quale fosse il modo migliore per andarsene, né credevo ci volesse tanto più coraggio di quello che serve a dichiarare il proprio amore a una persona. Immagino il suicidio come una cura istantanea che cancella di colpo i mali e allo stesso tempo un modo per barare sulla vita. Mi sembra qualcosa di disonesto. C’è solo una cosa che m’impedisce di farlo ed è l’ostinazione di poter rivivere la felicità di un tempo. Non ho ancora accettato il fatto che non potrò mai più rivederlo e quando ci riuscirò forse ne sarò capace o forse il tempo avrà assopito il mio male. Intanto vado avanti a testa bassa nell’assurda speranza di poterlo rivedere, anche solo un istante.
Seconda fermata. Avevo accolto di malavoglia l’invito di Mari di cenare a casa sua in compagnia di alcuni amici, ma alla fine avevo accettato. Come al solito ero stata assorta nei miei pensieri fino ad estraniarmi dal resto e totalmente priva d’interesse per gli altri; avevo scambiato poco più di qualche parola giusto per non contravvenire alle regole della buona educazione. Mi sforzavo di nascondere il mio stato d’animo dietro un sorriso di cortesia perennemente stampato sulle labbra, ma era come se gli altri riconoscessero il mio dolore quasi fosse la mia nuova pelle. Gli occhi non mentono mai e io lo sapevo bene, per questo evitavo gli sguardi, perchè non vedessero la disperazione della mia anima.
Avevo mangiato poco e bevuto ancor meno, da tempo avevo imparato quanto sia inutile cercare di affogare i dispiaceri nell'alcol. Mari cercava di coinvolgermi nei discorsi, ma io ero sempre più chiusa nella prigione del mio corpo. Le ero comunque grata per gli sforzi che faceva e prima di salutarla dissi:
‑ Ti voglio bene Mari ‑
‑ Come due sorelle ‑
Poi ero scesa ad aspettare l’autobus che mi avrebbe riportata a casa.
Ero stanca e il vetro del finestrino trasmetteva un freddo pungente che mi penetrava le ossa. Avevo quella sensazione febbrile che si prova quando ogni cosa a contatto con la pelle provoca fastidio. Il mio udito si era talmente abituato ai rumori all’interno dell’autobus da diventare impercettibili, quando un suono interruppe l’atmosfera di silenzio che mi circondava fungendo da isolate al mondo esterno. Risuonò nitido e limpido in mezzo agli altri come un proiettile che taglia l’aria fino a raggiungere le mie orecchie trapassandole, conficcandosi in profondità nel cervello. Subito non mi accorsi di conoscerlo, ma poco dopo capii che non potevo sbagliarmi, era proprio quel suono, lo conoscevo fin troppo bene e da quella sera in cui era successo tutto, era diventato un’ossessione. Era la stessa suoneria, la stessa che cambiò la mia vita scaraventandomi nell’ombra.
Mi voltai e vidi un uomo impegnato a rovistare nelle grandi tasche dell’impermeabile nero che indossava, alla ricerca del cellulare. Dentro me lo imploravo di rispondere al più presto. Quel suono era una tortura. Sentivo il battito del mio cuore impennarsi all’improvviso e la percezione dei miei sensi si era intensificata come succede agli animali quando si sentono braccati. Mi girai nuovamente e vidi il cellulare nella sua mano esitante. Sentivo una rabbia irrefrenabile salire dalle viscere, pronta a esplodere in un grido disperato di aiuto, quando finalmente quella musica cessò e ricacciai tutto in gola in un boccone amaro. Il ricordo di quella sera cominciò a riaffiorare dal profondo per farmi rivivere ogni istante una seconda volta.
Erano passate poche settimane, ma la lontananza le aveva fatte scorrere con la lentezza dell’eternità. Per motivi di lavoro lui si era dovuto allontanare e ora che finalmente i nostri cuori si sarebbero rincontrati dopo tanta nostalgia, volevo che tutto fosse perfetto. Desideravo rivederlo, sentire il suo profumo sulla mia pelle, le nostre labbra ritrovarsi con la stessa tenerezza di sempre. Immaginavo i nostri corpi fondersi uno nell’altro fino a diventare un blocco unico di marmo, nel procedimento inverso in cui l’artigiano cerca di dividere le forme e definire i confini, io volevo fossero una cosa sola, indistinguibile.
Stavo preparando la tavola, avevo disposto i piatti di porcellana uno di fronte all’altro sulla tovaglia di stoffa bianca che usavo nelle occasioni importanti, i calici di cristallo pronti al brindisi, le stoviglie migliori e i tovaglioli a corredo. Una composizione di fiori profumati adornava il centrotavola insieme a due candele rosse. Era tutto perfetto.
Passò un’ora, poi un’altra mezz’ora, ma lui non arrivò. A ogni giro di orologio la mia preoccupazione aumentava finché il cellulare cominciò a suonare vibrando sopra il legno del tavolo come una falena che non riesce a rialzarsi. Quella suoneria era inconfondibile, la stessa che mi trapassava l’anima, in quel freddo autobus che mi avrebbe portato a casa. Il numero era sconosciuto e quando risposi la voce inespressiva di un poliziotto mi raggelò il sangue.
‑ Parlo con Bianca Bòis? ‑
‑ Si sono io chi parla? ‑
‑ Sono un poliziotto della stradale, suo marito ha avuto un incidente. Una volante arriverà a casa sua tra pochi minuti ‑ Mi portarono sul luogo dell’incidente. Cominciai a percorrere con lo sguardo ogni dettaglio di quella macchina accartocciata su se stessa in un groviglio di dolore. Un intreccio di metallo, plastica e lamiere era tutto ciò che rimaneva dell’automobile. Le ruote erano saltate fuori dalla loro sede nella violenza dell’impatto finendo ai bordi della strada e per terra le schegge dei vetri frantumati luccicavano sull’asfalto. Una parte del parabrezza aveva resistito, ma portava visibili i segni dell’urto che si diramavano dal centro verso l’esterno come la fitta maglia di una ragnatela. Le portiere erano infossate all’interno, i sedili trafitti dal metallo, il cofano, rovesciato su sé stesso, lasciava intravedere le parti del motore. Tutto era ricoperto da quei piccoli frammenti di vetro che brillavano alla luce dei lampioni accesi come tanti occhi nella notte.
Sentii un fischio sordo premere con sempre più violenza sui timpani accecandomi la vista, il cuore cominciò a pulsare incessantemente nella gola, nei polsi, in ogni arteria del mio corpo, finché svenni.
Quella notte il medico legale allungò il lenzuolo verde dell’ospedale fin sopra la nuca di mio marito in modo da coprire la morte che si era impossessata del suo corpo. Non sapeva che con quel gesto stava coprendo anche il mio di viso, sotto una coperta di dolore e sofferenza da cui non filtrava nessuna luce. Da quel giorno non avevo più avuto un cellulare.
Terza fermata. Ero rintanata dentro me stessa per nascondermi al mondo. Lo sforzo di quel ricordo aveva prosciugato ogni mia energia lasciandomi esausta, con il solo desiderio di arrivare il più presto a casa.
È possibile avere nostalgia di momenti che devono ancora passare, d’istanti che non sono mai trascorsi? È possibile immaginare frammenti di una vita che non si ha vissuto con una forza tale da confondere i ricordi con i desideri? Quante cose avrei potuto fare con lui se fosse ancora qui, quanti baci, sguardi, risate, sono andati persi e non potranno più tornare. Per questo io provo nostalgia, per dei ricordi che devono ancora passare, che non potrò mai più vivere.
I discordi di due ragazzi seduti nei sedili posteriori dell’autobus, attirarono la mia attenzione. Erano uno fianco all’altro e si scambiavano battute gesticolando vivacemente con le mani. Facevo fatica a seguire chiaramente la loro conversazione perchè la distanza che ci separava disperdeva le parole lungo il percorso, inoltre il rumore del motore assorbiva ogni suono, ma quello che riuscii a sentire m’incuriosì molto.
‑ ...e tu cosa faresti se fossi il Camaleonte? ‑
‑ Se fossi il Camaleonte diventerei il marito della professoressa di matematica. Andrei a prenderla a scuola appena finite le lezioni e mi chiuderei in classe da solo con lei. Secondo me la prof è una che ci sa fare, sembra tanto severa e bigotta, ma sotto le coperte deve essere una vera selvaggia! ‑
‑ Non sarebbe meglio che tu facessi qualcosa per i tuoi voti? Magari se ti trasformassi in lei invece che in suo marito potresti metterti un bel 10 sul registro ‑
Disse l’amico.
‑ Ah davvero... ho cambiato idea, sai cosa farei se fossi il Camaleonte? Me la spasserei con la tua ragazza... ‑
Risero entrambi spingendosi in modo amichevole. Però di cosa stavano parlando? Dove avevano sentito parlare di questo “Camaleonte” e soprattutto, chi era? Mi voltai rinunciando all’idea di vedere la mia curiosità di quel momento soddisfatta, quando un giornale, abbandonato su un sedile dell’autobus, attirò la mia attenzione. Era mal piegato sulle pagine interne e un articolo in bella mostra titolava: “Il Camaleonte”. La scritta sovrastava l’immagine raffigurante una sagoma umana colorata in nero su fondo bianco con al centro un grosso punto interrogativo anch’esso bianco. Presi in mano il giornale e cominciai a leggere l’articolo.
“ È solo una leggenda metropolitana o una voce priva di fondamento che passando di bocca in bocca si è trasformata nella storia di un mito? È noto come in ogni leggenda ci sia sempre un fondo di verità, anche se per ora è azzardato dire di più. Una cosa è certa: la centrale di polizia in questi giorni è stata sommersa letteralmente dalle telefonate di cittadini impauriti da quello che si presume essere un uomo capace di tramutare il proprio aspetto fisico. È stato battezzato “il Camaleonte” per la peculiare capacità, in comune con il rettile, di trasformare il proprio corpo.
Pronta è arrivata la risposta di alcuni esperti che negano nel modo più assoluto l’esistenza di un essere dotato di tali capacità, ma per chi crede ancora in qui fenomeni etichettati dalla scienza come “inspiegabili”, resterà affascinato da questa ipotesi.
Senza intenzione di creare allarmismo ci rivolgiamo la seguente domanda: se davvero il Camaleonte esistesse, che uso farebbe delle sue capacità? “
Quarta fermata. Una strana idea cominciò a farsi strada nella fitta rete dei miei pensieri.
Quinta fermata. L’arrivo.
7.
Con la naturalezza di un gesto della mano sinistra sistemò le ciocche dorate che le scendevano sul viso, dietro l’orecchio. Aveva la pelle chiara e delicata, che si scotta al primo audace sole primaverile, talmente candida che la luce rendeva trasparente facendo affiorare in superficie le piccole vene che la percorrevano. I suoi occhi di ghiaccio erano capaci di sciogliere qualunque persona le si trovasse davanti, dall’uomo più mite al più irrequieto. Sostenere il suo sguardo era come fissare l’infinito del cielo, potevi perderti nella sua profondità fino a rimanerne imprigionato; però nulla svelavano quei due occhi celesti del suo carattere, se non la spensieratezza del suo animo. La bocca affusolata, le mani lunghe e sottili, i capelli dorati, la pelle colore della luna, conferivano a Paula dei tratti nordici e molti sconosciuti le attribuivano spesso origini scandinave che non le appartenevano.
Mentre con una mano tenevo la cornetta stretta verso l’orecchio aiutandomi con la spalla e con l’altra digitavo il numero sulla tastiera, immaginavo Paula seduta alla scrivania nella redazione del giornale per cui lavorava. Mi trovavo in una cabina telefonica poco distante da casa, avevo poggiato il biglietto che portava scritto il numero del suo cellulare sopra l’apparecchio e senza esitazione aspettavo di sentire la sua voce. Quando sono al telefono ho spesso l’abitudine d’immaginare ciò che sta succedendo dall’altra parte del filo: la vedevo nel suo ufficio, più simile a un accogliente salotto, lungo e stretto, tappezzato di piante verdi che contribuivano a creare un ambiente piacevole. La luce del sole filtrava da un’ampia vetrata che riempiva l’intera parete alla sua destra, illuminando in modo uniforme l’interno. L’ufficio era situato ai piani intermedi di un grande palazzo a vetri e la vista che si respirava da quell’altezza si perdeva nell’imponenza degli edifici di fronte e negli scorci di cielo tra uno e l’altro. La postazione di Paula, identica alle altre, era formata da un grande tavolo bianco, colore ideale per non affaticare la vista, sul quale erano disposti alcuni fogli che la giornalista era intenta a esaminare. L’espressione senza espressione del suo volto, le gambe accavallate e la schiena curva in avanti, rivelavano lo sforzo per cercare la concentrazione. Tra le lunga dita teneva una penna che faceva oscillare ritmicamente dall’alto verso il basso, in un gesto meccanico di cui neppure se ne accorgeva. Di fonte a lei sulla scrivania: un computer, un telefono e un plico di riviste da leggere aspettavano in silenzio la sua attenzione, mentre sul soffitto le pale di un ventilatore mescolavano l’aria, producendo un lieve ronzio cui presto si faceva l’abitudine. Era così che la immaginavo.
Il telefono cominciò a suonare. Era libero.
‑ Pronto? ‑
‑ Sono Bianca, la sorella maggiore di Mari, sei tu Paula? ‑
‑ Sì, ciao Bianca! ‑
‑ Spero di non disturbarti, devo chiederti un favore e solo tu puoi aiutarmi ‑
‑ Ok dimmi ‑
Paula ed io non avevamo niente in comune, a parte Mari. Non ero mai riuscita a capire fino in fondo come fosse veramente e questo aveva contribuito a frenare l’interesse ad approfondire una conoscenza che non è mai sfociata in amicizia vera. In lei riconoscevo la spontaneità di ogni suo gesto, quasi fosse guidata in ogni scelta dall’istinto, e insito in esso l’imprevedibilità di ogni reazione. Allo stesso tempo la sua grande testardaggine nel raggiungere gli obiettivi che si prefiggeva la portava spesso ad essere fraintesa dagli altri, per questo fin dai tempi della scuola la sua ingenuità era facilmente scambiata dai ragazzi per voluttà e la sua ostinazione tradotta in: ogni mezzo è lecito per raggiungere il fine. Forse l’ostinazione che l’aveva portata a lavorare per il più importante quotidiano della città era la stessa dei tempi della scuola.
Mari condivideva con lei la stessa spensieratezza e la stessa voglia di divertimento che un tempo era anche mia. Erano sempre state grandi amiche fin dall’infanzia, i loro caratteri si erano plasmati a vicenda crescendo insieme come due sorelle ed io avevo imparato a volerle bene senza neppure accorgermene.
‑ Ho letto l’articolo di ieri titolato “Il Camaleonte” ‑
‑ Si è stato scritto da un collega ‑
‑ Avrei bisogno di tutto il materiale riguardante l’articolo, qualunque cosa possa essere utile: fonti, testimonianze, denunce. Paula, devo sapere se si tratta di un’invenzione o esiste un fondo di verità, nel pezzo si dice che la centrale di polizia è stata sommersa da un gran numero di denunce. È vero? ‑
Seguii un momento di silenzio per prendere fiato prima di una confessione.
‑ È proprio così importante per te Bianca? ‑
‑ Si molto ‑
‑ Non so perchè tu sia così interessata a questo articolo, ma ti racconterò tutto. Solo non farne parola con nessuno ‑
La voce di Paula divenne poco più forte di un sussurro, non voleva che altre orecchie udissero la nostra conversazione. Sentii il rumore dei suoi tacchi, che si alzavano dalla sedia della scrivania e si allontanavano diventando sempre più impercettibili, poi una porta si chiuse e i suoi passi uscirono dall’ombra del silenzio venendomi incontro. Percepii infine la sua mano afferrare la cornetta e sollevarla verso il viso, il suo respiro si diffuse nel microfono.
‑ L’articolo “Il Camaleonte” ha una storia particolare, è il risultato di una mediazione tra la centrale di polizia e gli organi di stampa con lo scopo di smorzare i toni di un fenomeno che sta coinvolgendo la nostra città e i suoi abitanti. Le centrali di polizia sono state invase come si dice nell’articolo, da una serie di denunce tra loro molto simili che presentano in particolare la stessa successione di eventi. La cosa non è potuta restare nascosta, come avrebbero voluto gli organi di sicurezza poiché le indagini relative al caso erano ancora in corso e per non creare allarmismo inutile nella popolazione, perchè la capacità onnivora della stampa di infiltrarsi dappertutto e di trasformare ogni persona in una fonte da cui attingere notizie, aveva fatto emergere la verità dei fatti. Gli organi di sicurezza consci che la notizia era trapelata, non hanno potuto fare altro che mediare per smorzare i toni con cui sarebbe stata pubblicata facendole assumere i panni di articolo di costume o addirittura di un’invenzione giornalistica ‑
Un lungo sospiro interruppe la sua voce e la mia attenzione. Poi riprese.
‑ Le redazioni dei vari giornali hanno tra loro un rapporto quasi di collaborazione al contrario di ciò che si pensi. In altre parole le une copiano le altre per non perdere gli articoli più importanti del giorno. Così si è resa necessaria la pubblicazione dell’articolo, per non cedere il passo alle redazioni concorrenti sul mercato. Articolo che altrimenti non sarebbe mai stato pubblicato.
L’esposizione dei fatti messi a verbale nelle varie denunce giunte alla polizia rivelano la stessa accusa nei riguardi di un individuo non identificato, tale individuo travestendosi perfettamente nel coniuge approfitterebbe della situazione. Questi sono gli elementi reali da cui trarre delle conclusioni, mentre la possibilità messa in evidenza nell’articolo che esista veramente un essere capace di copiare l’aspetto di altre persone, è una supposizione giornalistica senza fondamenti ‑
Si fermò un momento aspettando una mia reazione a quelle parole. Sentivo che entrambe sapevamo prima di parlare quale sarebbe stata la mia domanda e quale la risposta.
‑ Mari mi ha raccontato quello che ti è successo, quindi ti chiedo di rispondere sinceramente a questa domanda: credi all’esistenza del Camaleonte? ‑
‑ Ti ho raccontato tutto questo per l’amicizia che mi lega a Mari e anche per me stessa. Se qualcuno venisse a sapere che ti ho raccontato tutto, rischierei il posto ‑
Poi aggiunse:
‑ Sì, ci credo ‑
‑ Mi aiuterai allora? ‑
‑ Dammi una settimana ‑
Mi sforzai di trattenere la frase che mi ronzava nel cervello. Mi sentivo in dovere di confessarle quali fossero le mie intenzioni dopo tutto quello che mi aveva raccontato a suo rischio, ma ero certa lo avesse già capito e forse per questo aveva deciso di aiutarmi, quindi non aggiunsi altro.
Dovevo aspettare una settimana intera con quella frase smorzata in gola che diceva: ti troverò!
8.
Immagino un labirinto e io ci sono nel mezzo, con gli occhi al cielo, mentre grido fuori la mia anima e vomito la merda che ho nel cuore. Mi muovo tra quelle arterie indecifrabili e quando m’illudo di avvicinarmi all’uscita, in realtà mi allontano sempre più dalla meta. Non esistono formule e nemmeno logica, non esiste pietà finché vivi; il tuo percorso sarà un vagare a caso per i sentieri del mondo e quelli del cuore, come in un labirinto. Non esistono disegni prestabiliti o piani divini per ciascuno di noi, siamo sballottati da un estremo all’altro con la forza di una bufera.
E finisce che l’estraneità di quel labirinto dal quale vorremmo fuggire lontano, acquisti la familiarità della nostra casa, e la paura di non poter uscire si tramuti nel terrore di non poterne più fare a meno.
Era passata una settimana e sentivo addosso un’eccitazione che da molto tempo non provavo. Era l’aspettativa di un’attesa che aveva visto passare i giorni goccia dopo goccia in un lento stillicidio, tra la noia e la solitudine che solo il pensiero di rivederlo riusciva a placare, come una pozza d’acqua nel deserto da cui attingere nuova speranza. Non sapevo niente: cosa mi avrebbe portato Paula, se sarebbe stato utile, in che modo avrei cominciato la mia ricerca, se sarebbe servito. Ma la mia mente correva molto più veloce del tempo e mi sentivo piena di fiducia nel superare i limiti delle difficoltà che avrei incontrato lungo il percorso. Immaginavo spesso il momento in cui mi sarei trovata faccia a faccia con il Camaleonte e non pensavo ai passi che avrei dovuto compiere per riuscirci veramente, semplicemente mi lasciavo cullare da quel pensiero ed era come guardare un film partendo dal finale tralasciando tutto il resto. Semplicemente sognavo. Però non era solo il senso di eccitazione che sentivo tatuato sulla pelle, ma anche la paura di seguire un’illusione che per quanto dentro la mia testa somigliasse al reale, presto o tardi avrebbe potuto rivelarsi un fallimento.
Era passata una settimana e sentivo il dolore cominciare sempre più ad assumere la forma di una dimora angusta, con le pareti di cartone e il pavimento in terra battuta, dove lo spazio che mi circonda è solamente necessario per respirare, a cui però non avrei rinunciato facilmente; nonostante tutto cominciavo a sentirla casa mia. Non mi riusciva difficile ora capire quelle persone che vivendo in baracche oppure in una cantina, nella cella di una prigione o nel letto di un ospedale, chiamano quel luogo “casa” con la certezza di non poter vivere senza. E quando questi luoghi non saranno più loro, quando non saranno più la loro casa, proveranno per essi nostalgia; non delle porte, dei mobili, delle finestre o delle pareti, nostalgia delle abitudini.
Mi stavo abituando al dolore come fosse la mia ombra. Due persone costrette a vivere nella stessa casa instaurano legami forti, allo stesso modo ho fatto io, costretta a vivere fianco a fianco con il mio male. Ma le abitudini di quando ero felice avevano radici ben più profonde e pur di ritrovarle ero disposta a scavare a fondo per uscire dalla tana buia in cui mi ero rannicchiata, abbandonando tutto per respirare nuovamente la vita.
Era passata una settimana e Paula arrivò come promesso, ma non era la solita Paula, non quella che parla per un’ora intera senza dire nulla, che tratta ogni persona come fosse la sua migliore amica, che riempie una stanza con il suo sorriso e che diffonde il suo entusiasmo come un virus contagioso. Non era la Paula che avevo imparato a conoscere. Rimasi turbata senza sapere come comportarmi. Per capire le persone cerco di raffrontare ciò che provano, o almeno quello che io penso stiano provando, e come lo vivono, al modo in cui io lo vivo, secondo la misura della mia esperienza. Così la logica senza logica del mio ragionamento mi portò a pensare che se io affronto il dolore nell’isolamento della solitudine, anche per Paula doveva essere così. In quel momento l’empatia non mi suggerì che forse quello di cui aveva bisogno era una persona con la quale sfogarsi. Alle volte buttare fuori tutto è come liberarsi di un peso che altrimenti ti trascina sempre più verso il fondo. Non le chiesi nulla.
Era entrata nell’appartamento stringendo sotto il braccio un plico di fogli che parevano pesargli nella mano. Fece due passi e lo posò sul tavolo del soggiorno dicendo che era il massimo che aveva potuto fare. La ringraziai molto e le offrii una fetta di torta che rifiutò. Non mi chiese nulla. Mi avvicinai al plico di fogli con la stessa eccitazione di una bambina che scarta un regalo e cominciai subito a sfogliarlo chinandomi verso il tavolo. Per un attimo Paula rimase immobile nel soggiorno poi i suoi passi risuonarono nelle mie orecchie come un eco lontano che si avvia verso la porta. Si fermò qualche istante all’altezza del mobiletto vicino all’ingresso poi disse solo:
‑ Ciao ‑
Mi voltai di scatto ricambiando il saluto, ma lei era già uscita lasciando la porta spalancata. La richiusi e nel tornare verso il soggiorno urtai il mobiletto con la gamba. Risistemai le foto che erano cadute e mi accorsi immediatamente che mancava qualcosa. Le chiavi del condominio più alto della città non c’erano, eppure le lasciavo sempre li. Chissà dove le avevo messe... ma dove ho la testa?
9.
Ero seduta a gambe accavallate cercando di decifrare l’inchiostro di quelle pagine per ricavarci un indizio, qualcosa di anche infinitamente insignificante da cui poter partire. Gli attrezzi del lavoro erano il plico di fogli da studiare, un evidenziatore giallo, una penna stilo e una tazza di caffè fumante che impregnava l’aria del suo aroma amaro. Il mio studio? Il tavolo del soggiorno.
Il plico di fogli era una raccolta delle denunce pervenute alla stazione di polizia relative al caso che i giornali avevano battezzato “Il Camaleonte” e per ciascun denunciatore era stilato un identikit completo di dati anagrafici e foto d’identificazione. Non potevo chiedere di meglio e mi sentivo un poco in colpa pensando a quanto aveva dovuto rischiare Paula per ottenere quelle informazioni, d’altronde c’erano molti dati sensibili. Dopo una prima occhiata veloce cominciai a leggere attentamente pagina per pagina, parola per parola, per essere certa che nulla potesse sfuggire alla mia attenzione. La mia agitazione mal si conciliava con la pazienza che pretendeva il lavoro. Ripensai a quando frequentavo la scuola, ai pomeriggi passati in casa a studiare, alle energie che dovevo profondere nell’impegno. Avevo la sindrome del foglio bianco al contrario: tanta voglia, poche idee, nessuno spunto da cui partire...almeno non dovevo scrivere. Meglio un sorso di caffè.
Vestivo i panni di un’investigatrice alle prese con un indagato che non vuole confessare. Non dovevo perdere il controllo, in questi casi bisogna essere bravi a leggere tra le righe, a dare un senso alle parole che ne sono prive; bisogna domandare, chiedere, richiedere e ridomandare. È una lotta a chi resiste di più alla noia. Cominciai a leggere, rileggere, studiare e ristudiare.
Ma io chi ero? Poliziotto buono o poliziotto cattivo?
Bianca A ‑ Non conosco il nome, il vero aspetto, dove vive, nessun indizio. Come posso trovare un fantasma? Non è una ricerca, né investigazione, qui si gioca a mosca cieca! Chiudi gli occhi e buttati, qualcuno prenderai! ‑
Bianca B ‑ Calma, ci vuole calma. Prendi un bel respiro. Ricordi com’era a scuola? Se il professore ti chiedeva di parlare riguardo un argomento a scelta allora era il panico, ma se ti rivolgeva una domanda specifica sapevi subito cosa rispondere. Affrontare il problema non nella sua globalità, ma scomporlo in piccole unità a cui dare una risposta. La somma darà il risultato. ‑
Bianca A ‑ Andiamo per gradi allora. Qual è la prima domanda che un investigatore rivolge a sé stesso per cominciare le indagini? ‑
Bianca B ‑ Parte da un indizio ‑
Bianca A ‑ Si certo un indizio. E dove si trova questo indizio? Sul luogo del delitto ‑
Bianca B ‑ Che nel nostro caso sarebbero le testimonianze di questi fogli. Non abbiamo niente di materiale, non possiamo studiare il luogo dove ha colpito di persona, dobbiamo solo cercare qualche elemento utile in mezzo a questo inchiostro ‑
Bianca A ‑ Allora... di norma il Camaleonte s’introduce nelle abitazioni dopo aver mutato forma e durante le ore in cui il coniuge della vittima è assente. Quindi è logico pensare che esegua svariati appostamenti per studiare le abitudini della propria preda ‑
Bianca B ‑ Proviamo allora a formulare un identikit della vittima ideale ‑
Bianca A ‑ Sono tutte donne, tra i diciotto e trent’anni. Sposate e di bell’aspetto, a giudicare dalle foto d’identificazione ‑
Bianca B ‑ Ecco il movente! ‑
Bianca A e B ‑ È per sesso! ‑
Bianca A ‑ Ma come ho fatto a non capirlo prima? Prova a metterti nei suoi panni. Cosa farebbe un uomo con quelle capacità? Basta fare uno più uno: le sue vittime sono tutte donne molto belle e inoltre c’è la testimonianza di Paula che mi ha raccontato Mari ‑
Bianca B ‑ Fino a qui ci siamo, è un’ipotesi molto valida ‑
Cominciai a scorrere le denunce per trovare conferma alla mia ipotesi. Leggevo il nome, guardavo la foto. Erano tutte donne, erano tutte belle, ma la cosa che mi colpì maggiormente era che tutte quante erano sposate. Perchè il Camaleonte s’interessava solo alle donne sposate? Qual era il suo modo di pensare? Era un domanda a cui non riuscivo a trovare risposta. Dovevo procedere per tentativi, formulare ipotesi su ipotesi, scegliere le più attendibili e dimostrarle, come si usa nella ricerca scientifica.
I verbali di denuncia si riferivano tutti a violazione di domicilio, ma in nessuno di essi era esplicitato il fine del reato, nessuno avanzava sospetti sul conto di alcuno.
Bianca A ‑ C’è un altro particolare che ho notato: il Camaleonte non colpisce mai più di due volte la stessa vittima ‑
Bianca B ‑ Tornare sul luogo del reato aumenta le probabilità di essere scoperti. Ricordi cosa disse Mari quando ci raccontò di Paula? La prima volta non aveva dato importanza all’accaduto, la seconda volta cominciava a sospettare. Era impaurita al punto da prendere delle precauzioni: sottoporre al marito, ogni qual volta tornasse a casa, un quesito cui solo loro due conoscevano la risposta. Deve essere veramente molto prudente questo Camaleonte, se si fosse recato nuovamente da Paula sarebbe stato scoperto ‑
Bianca A ‑ Quindi è tutto inutile! Questi fogli sono carta straccia. Se non andrà mai più da queste donne, cosa me ne faccio dei loro dati, dei loro indirizzi!? Ci stiamo arrampicando sugli specchi. Non arriveremo mai a una conclusione. Io voglio trovarlo! Se sapessimo dove abita, non sappiamo da dove cominciare ‑
Un altro sorso di caffè. Ero rassegnata, ma non potevo fare a meno di pensarci. Passarono alcuni minuti. Lo sguardo perso nel vuoto, gli occhi spalancati senza un battito di palpebra, alla ricerca di una verità che non arrivava.
Bianca B ‑ Aspetta un momento, solo un momento. C’è una cosa che possiamo sapere: dove colpisce e quindi dove colpirà. Questi fogli sono ancora utili ‑
Bianca A ‑ È inutile. Non colpisce mai nello stesso punto più di due volte e non pensare che io non abbia già pensato a questo: ho letto attentamente l’indirizzo di ognuna di queste donne e non c’è nessun criterio di scelta, sono sparse in ogni punto della città. Se fossero tutte nella parte meridionale della città, per esempio, avremmo un punto di partenza, ma purtroppo non è così ‑
Bianca B ‑ Si questo è vero. Però sulle denunce è riportata la data in cui le vittime hanno subito il reato. Se ricostruiamo il percorso dalla prima denuncia all’ultima, magari un filo logico lo troviamo. Potemmo capire il criterio dei suoi spostamenti ‑
Bianca A ‑ Ma certo! Sei un genio Bianca ‑
Andai nella mia stanza di corsa, dove ero sicura che nascosta da qualche parte ci fosse una vecchia cartina della città. Trovata! Tornai nel soggiorno e la spiegai sul tavolo. Con un cerchietto segnavo il luogo dove il Camaleonte aveva colpito e sotto scrivevo la data in cui era accaduto. Non ci potevo credere. Sulla mappa cominciò a delinearsi quel punto di partenza da cui cominciare le indagini che tanto desideravo. Quei cerchietti e quelle date spiegavano meglio di qualsiasi parola gli spostamenti del Camaleonte: si stava dirigendo sempre più a nord della città, era arrivato quasi al punto più estremo e da li dovevano cominciare le mie ricerche.
Bianca B ‑ Rimane solo un punto da risolvere: come faccio a trovare qualcuno di cui non conosco l’aspetto? ‑
10.
Nessuna certezza, nessun indirizzo o nome, solo supposizioni con il dubbio della verità che mi perseguita. La linea di confine tra realtà e fantasia era così sottile che in certi momenti pensavo che tutta questa storia fosse solo una grossa illusione, nata e sviluppata nella mia testa soltanto. Ma l’unico modo per scoprirlo era andare avanti. Non avevo nulla da perdere e questo pensiero mi rendeva forte. Dovevo risistemare le idee, riorganizzare tutti i ragionamenti per scoprire se avevo tralasciato qualcosa d’importante e infine elaborare un piano d’azione per riuscire a trovare il Camaleonte. Perchè un investigatore formula delle ipotesi, analizza le prove, studia ogni più piccolo particolare nella sua più profonda intimità, ma infine deve arrivare a una conclusione: trovare il colpevole.
Avevo sentito parlare della regola delle cinque W, utilizzata sia dai giornalisti che dagli investigatori per sintetizzare le informazioni principali e organizzarle secondo uno schema semplice e preciso. Consiste nel porsi le seguenti domande cercando di trovare una risposta per ognuna: dove? Perchè? Quando? Come? Chi? Una volta risposto a tutte cinque potrò arrivare a un risultato. La soluzione sarà la somma degli elementi.
Dove? I cerchi e le relative date che l’inchiostro della biro segnava sulla mappa della città erano le tappe di un tracciato senza meta, percorso da un uomo senza nome. I passi che il Camaleonte aveva mosso avevano lasciato un’impronta indelebile a testimonianza del suo passaggio. Era sufficiente seguirli per capire dove avrebbero condotto e già mi figuravo una grossa X rossa nella zona più a nord della città: il mio punto di partenza e con un po’ di fortuna anche quello di arrivo. Cosa avrebbe fatto il Camaleonte una volta oltrepassato il punto più estremo del suo percorso, che come una linea verticale spaccava in due la città, probabilmente non lo avrei mai saputo. Non ci volevo nemmeno pensare. Era questa la mia sola occasione.
+
Perchè? Le vittime sono tutte donne molto belle, il Camaleonte ha la possibilità di cambiare il proprio aspetto esteriore, qualunque donna può arrivare a capire facilmente che il movente può essere uno e uno solo: per sesso! Ma perchè scelga tra le sue vittime solamente donne sposate è un perchè a cui non riesco a trovare risposta.
+
Quando? Non c’era filo logico nell’orario temporale della giornata in cui il Camaleonte agiva, poteva essere a qualsiasi ora, indifferentemente di giorno o di notte. E non c’era neppure consequenzialità nei giorni, alcune settimane si muoveva svariate volte e altre settimane che della sua esistenza non lasciavano traccia. Certo era che le abitudini del coniuge della vittima e della vittima stessa, dovevano conciliarsi con le sue, come un amante che s’intrufola nel letto dell’amata quando è sicuro dell’assenza del marito; con la sola differenza che anche l’amata, in questo caso, era all’oscuro di tutto.
+
Come? Una volta cambiato aspetto per il Camaleonte dovrebbe essere un gioco semplice e tutto sommato senza troppi rischi approfittare della vittima scelta. Nella scelta della vittima risiede invece la vera difficoltà: studiare la vita delle persone con lo scrupolo e l’attenzione del più attento degli osservatori non è esercizio da poco. È un gioco di sguardi, ci vuole tanta capacità di osservare gli altri quanta abilità nell’evitare gli sguardi altrui per non essere scoperto.
È possibile che durante le settimane in cui non sono pervenute denunce il Camaleonte si dedichi pienamente in questo.
+
Chi? Senza volto, senza nome, senza età. Potrebbe essere chiunque e nessuno al tempo stesso. Un fantasma tra i vivi e il più invisibile tra i fantasmi.
=
Per trovare il Camaleonte dovevo trasformarmi nel Camaleonte, pensare come lui, cercare le sue stesse vittime tra la gente.
11.
Drinn!!Drinn!!
‑ Arrivo! Un momento... ‑
Aprì la porta una donna sulla quarantina, qualche ruga di troppo sulla tela abbronzata del suo viso, un nido di capelli ossigenati in disordine sulla testa e un paio d’occhiali da vista stile anni sessanta a incorniciarle gli occhi. Reggeva nella mano una tazza di tè fumante e dall’interno dell’abitazione proveniva un intenso odore di tabacco.
‑ Buona sera, mi chiamo Bianca, lavoro per l’agenzia di Statistica e Ricerca. Stiamo svolgendo un’indagine sulla famiglia e vorrei porle alcune semplici domande. Non le ruberò molto tempo ‑
‑ Non ho mai sentito parlare di questa agenzia... ma so bene dove vuole andare a parare. È la solita indagine di mercato e alla fine riuscirete a vendermi chissà quale apparecchio inutile convincendomi che non posso fare a meno di averne bisogno ‑
‑ No, le assicuro che non voglio venderle niente, è una semplice indagine statistica presa su un campione di persone ‑
‑ Bè comunque io vivo sola, sono tre anni che sono sola perciò non posso aiutarla ‑
‑ Scusi il disturbo, arrivederci ‑
In quel momento un piccolo cane bianco a macchie marroni si lanciò a gran velocità fuori dalla porta facendo svolazzare la vestaglia rosa della signora.
‑ Torna qui!!...ha visto mi ha fatto scappare il cane...Zeus!! Zeus!! ‑
‑ Maledette statistiche ‑
Biascicò sottovoce.
‑ Buonasera, sto volgendo un’indagine sulla famiglia per una società di Ricerca e Statistica, sono solo poche domande ‑
‑ Entri pure ‑
Era una donna molto bella e gentile, mi fece accomodare e mi offrì un caffè che rifiutai. Mi disse che aveva ventotto anni, era sposata da due, non avevano figli. Si chiamava Marianne.
‑ Marianne lei lavora? ‑
‑ Sono infermiera nel reparto di radiologia all’ospedale pubblico ‑
‑ Qual è il suo orario di lavoro? ‑
‑ La mattina dalle otto alle dodici, poi ho pausa pranzo fino alle due e finisco di lavorare alle cinque ‑
‑ Ha qualche passatempo o passione che sta coltivando in questo periodo? ‑
‑ Studio pianoforte da quando ero piccola e ora insegno alla scuola musicale del quartiere., il martedì e il giovedì ‑
Il marito gestiva un piccolo bar di nome “Eclisse” e il lavoro lo teneva lontano da casa fino a tardi. Era la vittima perfetta!
‑ Un’ultima domanda. Non le è mai capitato in questo ultimo periodo di notare qualche persona sospetta aggirarsi nei pressi della sua abitazione, o non so, magari qualcuno che abbia tentato di entrare in casa sua oppure qualche atteggiamento strano di suo marito? ‑
‑ Ho capito cosa intende... si riferisce a quella strana storia del Camaleonte, sa l’ho letta sui giornali e le persone del quartiere non fanno che parlarne. Per me è tutta una grande invenzione, funziona così al giorno d’oggi: le fantasie vendono più della realtà e i redattori dei giornali lo sanno bene ‑
Entrò il marito. Pensai si fosse appena svegliato perchè camminava lentamente e trascinando i piedi, si dirigeva verso la moglie e qualcosa mi disse che aveva ascoltato la nostra conversazione.
‑ Ciao caro ‑
‑ Ah Marianne... se fossi io il Camaleonte quante cose farei... ‑
Le sue parole confermarono la mia supposizione.
‑ Appena alzato e già tanta voglia di scherzare? ‑
Arrivò dalla moglie e si scambiarono un bacio. Quanta invidia provai in quel momento, senza motivo mi vennero alla mente le parole di uno dei dieci comandamenti cristiani: “non desiderare la donna degli altri e non desiderare le cose degli altri” e perchè non c’era: non desiderare l’uomo altrui? Un pochino maschilista davvero. Ma quello che desideravo era la loro felicità, una cosa che io non avrei mai più potuto avere e per cui in quel momento provavo invidia. Volevo che fossero infelici , che tutto il mondo fosse infelice come lo ero io.
Se io non posso avere la felicità nessun altro può averla!
Che sentimento stupido l’invidia, è l’egoismo di desiderare il fallimento degli altri in modo che la misura del proprio fallimento non sia più così macroscopica. E c’è ancora chi per consolarsi ripete tra se e se la solita inutile frase: pensa a chi sta peggio di te. È questa la filosofia in cui crede chi cerca di mascherare la propria miseria, chi giustifica la propria infelicità in un destino avverso e non alza un dito per cambiare le cose. Io non dovevo essere così, dovevo essere diversa.
‑ Meglio che vada. Scusi il disturbo e arrivederci ‑
12.
Chi osserva un crimine, una violenza, senza fare nulla è come un complice, allo stesso modo chi conosce la verità e non la dice è come un bugiardo. Io non sapevo la verità, sapevo quello in cui credevo o ero obbligata a credere per trovare una speranza e per me era diventato tutto così naturale, così ovvio; era la mia verità, quella in cui credevo.
Stringevo tra le mani i nomi di quelle donne: Marianne, Laura, Clementine, Diletta, Lia, Claudia, Selene, Pilar. Erano le donne che corrispondevano all’identikit della possibile vittima del Camaleonte. Avevo mentito a ognuna di loro.
Ero il pescatore che getta l’esca viva nel mare per catturare la sua preda pur sapendo fin troppo bene che l’esca viene sempre mangiata. Potevo avvertirle, metterle in guardia su quello che sarebbe potuto succedere, ma non lo feci; lentamente mi ero trasformata nel complice silenzioso del Camaleonte.
Nella metà destra del mio cuore la speranza è la linfa che mi alimenta, il solo motivo che da un senso al svegliarsi la mattina e colora i giorni sbiaditi dall’indifferenza del tempo che passa. Sento il percorso vorticoso del sangue che mi attraversa il cervello. È una droga che esige sempre altra droga, senza mai trovare sazietà. Non è più la stessa cosa, il seme della speranza è germogliato e ha preso nuova forma, è diventato una parola nuova, è diventato: ossessione.
Nella metà sinistra la colpa, compromesso necessario per raggiungere il fine, unica soluzione per arrivare a una soluzione, ma a quale prezzo? Sono seduta sul sedile posteriore della mia vita e intanto aspetto. Osservo gli eventi scorrere dal finestrino, non sono io a condurre. Ho bagagli pieni di sogni interrotti, di progetti dimenticati, di speranze cancellate, chiusi a doppia mandata nelle profondità di me stessa. E ora la mia sola occasione si presenta in questa veste, esige le mie mani sporche di sangue, pretende che io faccia il male per essere felice.
13.
Strada principale densa di traffico, incorniciata da entrambi i lati dal marciapiede, faceva da spartiacque tra la schiera di abitazioni sulla destra e quelle di fronte. Erano case vecchie, appiccicate una all’altra come una fila di persone che si stringono per difendersi dal freddo; costruite durante la guerra a quella maniera per consentire una comoda via d’accesso tra una e l’altra in caso di necessità. La voce rombante delle automobili che scorrevano sulla strada arrivava prima alle orecchie che alla vista come il tuono che annuncia il lampo e al loro passaggio lasciavano dietro se una scia sonora che lentamente si perdeva nella lontananza. Era una giornata scura, il cielo avvolto da un mantello di nubi copriva il sole senza lasciare un solo spiraglio alla luce, ingrigendo le facciate di alcune abitazioni che altrimenti sarebbero state di colore brillante, facendole rassomigliare a facce tristi. Una giornata che alle sette del mattino è già sera.
Angoli stretti e vie buie, traffico di persone che si stringono nei cappotti, dirette chissà dove, ognuna per la sua strada, ognuna con il peso della vita da portare sulle spalle. Quanti perchè avevo nella testa cui non riuscivo a trovare risposta, ma le cose succedono, gli eventi accadono, spesso senza un motivo o forse quel motivo non riusciamo a capirlo e non rimane altro che accettarlo. In questo io non ero veramente capace. Non mi tornavano i conti con la felicità: per troppo tempo avevo sofferto e troppo poco era durata la felicità, la vita era in debito nei miei confronti, mi aveva tolto tutto lasciandomi nuda e sola a combattere un mondo troppo più grande di me.
Una fila di lampioni spenti, regolarmente distanziati tra loro, si ergeva dal marciapiede fino all’altezza degli scuri rossi della casa di Clementine. Sembravano rubini incastonati nella superficie chiara del muro, unica nota di colore in una giornata in bianco e nero. Una piccola scalinata che si srotolava come una lingua dalla porta d’ingresso, consentiva l’accesso all’abitazione. Mi ero sempre chiesta se ci fosse un motivo reale o fosse solamente una coincidenza, che la facciata delle case somigliasse così tanto al viso di una persona. Le finestre al posto degli occhi, la porta come bocca, la parvenza di un’espressione capace di suscitare una reazione anche minima come riesce a fare un viso triste o felice, per esempio. Fissavo negli occhi gli scuri color rubino che ricambiavano il mio sguardo. Chissà cosa vedevano...una donna sola dall’altro lato della strada, ferma immobile mentre tutto il mondo corre, senza di meglio da fare che compiacere la propria ossessione.
Erano trascorsi cinque giorni da quando avevo cominciato a sorvegliare le abitazioni delle possibili vittime, cercando di far combaciare ogni orario alla perfezione come i pezzi di un puzzle. Quello che avevo trovato era stato il freddo pungente portato dai venti del nord e la noia del tempo che quando non si ha nulla da fare scorre sempre più lentamente, ma del Camaleonte nessuna traccia. Ogni giorno da quando avevo cominciato le ricerche, la speranza nasceva con il nascere del sole la mattina, piena di una fiducia cieca che non guarda ai perchè e mi scaraventava giù dal letto come un cane che scalpita per uscire. Lentamente durante lo scorrere del giorno si trasformava in disillusione e arrivava la sera che era diventata rassegnazione. Una metamorfosi d’umore che si ripeteva costante.
Per combattere la noia delle ore che passavano un’identica all’altra, senz’altro da fare che osservare una casa e una strada, avevo inventato una specie di gioco mentale. Mi era rimasta impressa una frase che diceva: “la prima volta che si fa un’esperienza lo stupore e la passione che si profonderanno nel farla, renderanno quell’esperienza unica e indelebile. Per questo bisogna sempre ricercare cose nuove, perchè vengano fatte per la prima volta”. Così mi sforzavo di ricordare i momenti in cui per la prima volta avevo fatto un’esperienza. La prima volta che avevo guidato la macchina e sono finita dopo pochi metri in un giardino fermandomi appena in tempo per non sbattere contro un albero, la prima volta che avevo detto “ti amo” e la prima volta che avevo pianto per amore, il primo giorno di scuola, il primo bacio. Quando per la prima volta avevo fatto l’amore con lui, l’uomo della mia vita. Ricordo l’imbarazzo di scoprire un corpo nuovo, di sentire un profumo che non avevamo ancora sentito, di toccare dei lineamenti mai toccati prima, e questo ci rendeva impacciati come due amanti al loro primo incontro. La paura di fare o dire qualcosa che all’altro non sarebbe piaciuto ci frenava e il desiderio di dare piacere all’altro superava di gran lunga quello di compiacere il proprio. Alla fine lui disse:
‑ Voglio lasciarti un ricordo, così non ti dimenticherai mai di questo giorno ‑
Cominciò a baciarmi dolcemente sul collo sfiorandomi con le labbra umide, disegnando una figura che non riuscivo a riconoscere.
‑ Ora sulla tua pelle è tatuato il mio nome, la mia felicità è tua, trattala bene ‑
Era la prima volta che qualcuno mi diceva una frase tanto bella.
Tre cose mi avevano colpito di Clementine Conner: l’accento francese che conferiva una musicalità molto gradevole al suono delle sue parole, la luce dei suoi grandi occhi verdi, l’eleganza dei gesti più semplici. Per non parlare degli scuri rosso vermiglio della sua casa, anche se questa è una nota a parte del discorso. Aveva ventitré anni ed era nata a Lens in Francia. Si era sposata giovanissima a ventun anni con un professore e ricercatore universitario di nome Anthony Trenet, in carica alla cattedra della facoltà di geologia. Lei non aveva lavoro fisso, ma era impegnata nel sociale cui dedicava quattro ore del pomeriggio di ogni giorno. Aveva la passione per i film d’autore e ogni mercoledì sera andava al cinema per seguire la rassegna del cineforum. Questo era tutto quello che sapevo della vita di Clementine Conner.
Erano le cinque di pomeriggio, io osservavo la casa di Clementine da poco più di una mezz’ora, da quando lei era tornata dal lavoro. Avevo passato le ore dalle nove alle undici della mattina davanti a casa di Laura, una pittrice di talento che faceva composizioni di fiori secchi; dalle undici fino alle due di fronte alla casa di Selene, maestra d’asilo; ora alla casa di Clementine fino alle sette e la sera da Marianne. Nelle ore solitarie e indifferenti che passavo ad osservare la vita degli altri rivedevo la sintesi degli ultimi anni della mia esistenza. Aspettavo una chiamata al telefono della vita che non arrivava mai, attendevo senza fare io il numero ed essere la prima a chiamare, ripetendo a me stessa che domani quella telefonata sarebbe arrivata e se non domani, domani l’altro, ma quel giorno non arrivava mai. Infine decisi di chiamare io e composi un numero a dieci cifre, anzi una parola a dieci lettere: Camaleonte. Dall’altra parte della cornetta, per adesso, nessuno aveva ancora risposto.
I lampioni non erano ancora accesi, ma presto lo sarebbero stati. I rumori della strada e il chiasso delle persone si mescolavano in una sinfonia caotica scritta sul pentagramma di una città che scorreva sempre più veloce come un fiume in piena. In un momento tutto fu silenzio. Nella mia testa risuonava solo il rumore di passi regolari sull’asfalto, assordanti come colpi di cannone, lenti e precisi come il battito di un cuore. Erano i passi di Anthony Trenet che ritornava a casa. Seguivo con lo sguardo il suoi incedere sicuro, mentre tutto il resto era sparito, inghiottito in un’altra dimensione; per me esisteva solo lui e il mio istinto mi diceva urlando a squarciagola chi era veramente lui. Avevo paura di vedere realizzato il desiderio che era stato tutta la mia vita di quegli anni. Strinsi la mano chiudendo forte il pugno attorno alla tasca della giacca che indossavo. Al suo interno c’era un cosa molto importante, la più importante.
Arrivò alla piccola scalinata che dava l’accesso alla casa e senza fermarsi entrò. Tutto in me gridava l’identità nascosta che si celava dietro il nome di Anthony Trenet. Il cuore batteva così forte da impedirmi di respirare, pompava la frenesia nel sangue che m’impediva di pensare. La mia testa era piena di domande, dubbi, aspettative cominciate e poi lasciate a metà. Era come se l’anima volesse fuggire dal corpo. Passarono alcuni minuti, per me ore, giorni, anni. Anthony Trenet uscì dalla porta della casa, si guardò intorno e rapidamente si allontanò imboccando una stretta via laterale che fiancheggiava l’edificio. Mi precipitai senza pensare nella giungla del traffico con il cuore in gola, inseguita dal suono dei clacson di automobilisti inferociti che maledicevano la mia decisione. Lo raggiunsi nel vicolo e sorprendendolo da dietro lo scaraventai spalle al muro con una tenacia di cui non mi credevo capace. Lo guardai negli occhi tenendolo inchiodato al muro. Non disse niente.
‑ Io so chi sei, non sei quello che vuoi far credere ‑
‑ Questi non sono certo i modi che si addicono a una signora. Io sono Anthony Trenet, non so per chi mi abbia scambiato, ma la prego di lasciarmi subito andare ‑
‑ Non è vero, ti ho scoperto, devi fare una cosa per me ‑ Tirai fuori dalla tasca della giacca la foto dell’uomo che amavo. Era stata scattata in montagna, il suo viso sorridente in primo piano contro lo sfondo azzurro del bosco.
‑ Trasformati in lui ‑
‑ Io sono Anthony Trenet, cosa le fa pensare che possa fare una cosa del genere? Lei è pazza, mi lasci subito ‑
‑ Anthony Trenet o no se non lo fai mi metto a urlare, qui in mezzo a tutti ‑
Un istante. La via stretta in cui eravamo fu vuota. Lo sguardo dritto negli occhi. In un momento cambiarono colore. I lineamenti del viso cominciarono a muoversi. Lasciai la presa. L’uomo che amavo era finalmente davanti a me, così vicino che allungando la mano l’avrei toccato. Si era congelato il tempo, non un gesto, non una parola. Senza accorgermene le lacrime mi scesero dagli occhi. Ero felice.
Dopo un attimo il Camaleonte si voltò e scappò via veloce. Non lo rividi più.
14.
Notte senza luna, senza stelle nel cielo. Notte densa di silenzio, colore dell’inchiostro. Guardo il nulla fuori dalla finestra perchè i miei occhi non possono fare a meno di guardare e le mie palpebre non sono ancora così pesanti da lasciarmi dormire. Penso a tante cose, ma alla fine non penso a niente. Continuerò a provare finché avrò speranza e anche se dovessi impiegare una vita per rivederlo ancora, aspetterò. Non sono sicura se questo mi faccia più male o più bene, ci sono sognatori che dicono sia un bene inseguire un sogno anche se questo ti distrugge. Quando chiedi loro, dei loro sogni, non gli hanno mai realizzati. Soffrirò.
Risuonò in cielo un fuoco d’artificio che dipinse la notte di colore e diede voce al silenzio. La luce attraversò il vetro della finestra e travolse la stanza intera. Restai immobile. Un altro di pari intensità e abbagliante colore, poi un altro e un altro ancora, a intervalli regolari nella notte. Risuonavano in cielo come i rintocchi di un campanile che scandisce lo scorrere del tempo. Immaginavo la campana oscillare da un estremo all’altro colpita dai fuochi d’artificio che s’infrangono sulla superficie d’ottone liberando la loro anima lucente. Ero ipnotizzata da quel ritmo, impassibile a fissare il suono di un campanile che esisteva solo nella mia testa. Non avevo parole da pronunciare, né frasi a cui pensare, una sola domanda. Per chi suona la campana?
15.
Suonò il citofono, feci a finta di niente. Suonò il citofono, mi voltai e guardai l’ora sulla sveglia: i led luminosi segnavano le tre di mattina. Sarà lo scherzo idiota di qualche ragazzo. Suonò il citofono, scaraventai la coperta che avvolgeva il mio sonno ai bordi del letto, mi alzai di scatto, direzione: la porta. Avevo solo una maglietta bianca addosso a maniche corte e le mutande nere, non indossavo il reggiseno. I miei capelli erano arruffati e gli occhi talmente velati dal sonno che mi fidavo di più dalla memoria che avevo della casa, che della vista. Arrivai alla porta. Portai il citofono all’orecchio sputandoci dentro la mia rabbia:
‑ Chi è!? ‑
Non sono sicura di quello che sentii, ma avevo l’impressione di udire il pianto sommesso di qualcuno che cercava, senza riuscirci, di trattenere le lacrime.
‑ Bianca sono Mari ‑
La sua voce era rotta dal pianto. Arrivò come una doccia gelata che mi stordì lavando via ogni sintomo della stanchezza.
‑ Mari cos’è successo? Tu stai bene? Ti apro, sali ‑
Non ci fu risposta. Spalancai la porta d’ingresso, poi ripresi la cornetta in mano. Sentivo il suo rantolo attraversare il microfono, entrare nel mio orecchio e conficcarsi dritto nel cuore come una spina.
‑ Aspettami Mari, non andartene vengo giù subito ‑
Prima ancora di lasciare la cornetta sentii che cercava di radunare le forze per parlare. Rimasi alcuni secondi in attesa avvolgendo forte la mano intorno alla cornetta.
‑ Paula...è...morta ‑
